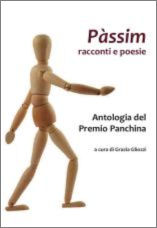PREMIO LETTERARIO PANCHINA
EDIZIONE 2009 - Racconti

L'unico ricordo
di Giorgio Ottaviani
Ho una sua vecchia foto di allora. Capelli scuri, lisci,
scriminatura su un lato. Nell’ovale minuto del viso due grandi
occhi chiari, davano notizia a chi li guardava, di ogni sua più
piccola emozione. La figura, anche se acerba, trasmetteva già
l’immagine di una femminilità, non ostentata, quanto piuttosto
offerta in modo inconsapevole.
Viveva con la famiglia in una borgata a ridosso della statale. Poco
dopo il ponte che superava la marana, una strada bianca, un tempo forse
asfaltata, raggiungeva un gruppo di case inframmezzate da orti e disposte
senza un ordine preciso. Si aprivano attorno prati incolti che d’
estate si coloravano del giallo del tarrasaco, interrotti qua e la da
siepi di sambuco. D’inverno si ricoprivano del colore sbiadito
e uniforme dell’erba bruciata dal gelo. Una borgata nata dopo
la guerra, quando la gente aveva ricominciato a vivere con quello che
gli era rimasto.
La domenica pomeriggio, mia madre prendeva l’autobus con le amiche
e andava in città. Andare in città per loro significava
raggiungere la periferia. Un quartiere popolare con una strada larga
fra due file di palazzoni anonimi, color pastello ed i negozi lungo
i marciapiedi. Comunque molto di più di quello che poteva loro
offrire la borgata dove vivevano.
Passavano il pomeriggio a guardare le vetrine e fare commenti sui ragazzi
che incrociavano.
Oppure si fermavano davanti al negozio di dischi della Ricordi, a osservare
i poster dei cantanti.
“Dio come mi piace quello li: ma chi è?”
“Che ne so, è uno americano”
“Non somiglia a Mario?”
“Mario chi? Quello che ti viene dietro? Ma se ha due orecchie
che se c’è vento vola via…”
“Dici così perché a te non ti fila”
“Capirai, sembrano due orecchie con un uomo in mezzo…”
Questo continuo prendersi in giro serviva a riempire il silenzio. Di
che avrebbero parlato altrimenti? Dei fratelli più piccoli a
cui dovevano pulire il culo, dell’aiuto che dovevano dare in casa?
Avrebbero potuto parlare dei loro sogni o delle loro aspirazioni, ma
per farlo avrebbero dovuto averne.
Quella domenica di metà giugno, anziché fare il solito
giro, era andata con le amiche al prato di fronte alla chiesa. Erano
arrivate le giostre.
Gironzolando fra i baracconi, ognuno con la sua musica, le sue luci,
colori, che si sovrapponevano e si mescolavano, si fermarono davanti
ai “calcinculo”.
“Ehi, un giro?”
Era il ragazzo della giostra: sui vent’anni, fisico asciutto e
volto abbronzato di chi lavora all’aperto.
“allora…, dico a voi quattro: un giro?”
Dall’accento si intuiva che non era italiano: forse slavo; cosa
che da sola bastava a galvanizzare le ragazze. E’ difficile fantasticare
sulle cose di tutti i giorni, ma di fronte a ciò che è
al di fuori del solito mondo, la fantasia si libera a costruire ipotesi
affascinanti, specie a sedici anni.
“No grazie” rispose Isa .
“ma parla per te” soffiò sottovoce fra i denti Paola.
Poi a voce alta, guardando il ragazzo negli occhi
“E’ che abbiamo finito i soldi…” mentì,
lasciando la frase sospesa.
“dai, offre Roman. Lo faccio perché se salgono quattro
belle ragazze, poi arrivano anche i ragazzi”
Un rapido scambio di sguardi
“dai Isa, andiamo”
Mia madre era già con le mani attaccate alle catene che sostenevano
il seggiolino, mentre Roman le faceva scivolare davanti la sbarra di
chiusura. Era emozionata, perché allora era ancora capace di
emozionarsi con un nulla.
“Come ti chiami?”
“Ornella”
“Bel nome….vediamo se riesci a prendere il fiocco”
Un giro, due, tre: risate, urla, mani allungate a cercare di afferrare
il fiocco.
“Uha, ho lo stomaco sottosopra” disse mia madre, appena
scesa, barcollando un po’. Il braccio di Roman l’afferrò
alle spalle.
“Vieni che ti porto a prendere qualcosa al bar”
E se la portò via prima che le sue amiche potessero reagire.
“Sei carina, quanti anni hai?”
“quasi diciassette”
“ e ce l’hai il ragazzo?”
“ma che t’importa a te?”
“niente, ma una carina come te ce l’ha di sicuro il ragazzo…”
Il braccio scivolò dalle spalle ai fianchi. Non andarono al bar.
La condusse oltre le giostre, dove una siepe di sambuco separava il
prato dagli orti coltivati. Lei lo seguì. Io non c’ero
e questo più o meno è quello che mi hanno raccontato.
Non ebbe il tempo di innamorarsi, di conoscerlo, di avere una storia.
In quelle vite di gente troppo presa a vivere il quotidiano non ce n'era
il tempo. Non so cosa successe davvero, ma non voglio credere che l’abbia
subito. Voglio pensare che in quel caldo pomeriggio d’estate,
lui le abbia preso il viso fra le mani e lei gli abbia risposto con
un sorriso, poi siano finiti stesi sull’erba: lei con il volto
arrossato il respiro spezzato e il sole che le brillava fra le ciglia
socchiuse mentre lui le affondava le dita nei capelli sudati. Poi le
giostre andarono via e Roman con loro, lasciandole me come unico ricordo.